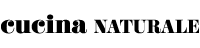Un granello di sabbia che ha iniziato a rotolare lentamente più di vent’anni fa e che è diventato un’enorme valanga. Un granello di sabbia composto dal piacere del buon vino, della buona tavola e della condivisone che ha catalizzato attorno a sé tutta un’altra serie di “cose buone”, che inevitabilmente erano anche “pulite e giuste”. La maggior parte dei nostri lettori avrà già capito: stiamo parlando di Slow Food, il movimento nato dal desiderio di condividere ed elevare ad azione culturale e politica la gioia di bersi un bicchiere di vino, Barolo per la precisione, alternativa a un mondo sempre di corsa, cieco, arrogante e ingiusto. Perché bersi un bicchiere di vino “in pace” presuppone che quel vino sia, non solo buono, ma prodotto valorizzando e salvaguardando il suo territorio e i viticoltori, senza sostanze che possano nuocere alla salute di chi lo beve e della terra da cui nasce. E che lo stesso discorso si possa fare per il pane e il salame che lo accompagnano. A far rotolare quel primo granello di sabbia è stato Carlo Petrini, che continua a tenere le fila di quello che è diventato il più grande, consapevole e godereccio movimento che si occupa del mondo del cibo e quindi della vita, perché, come dice Petrini stesso, senza cibo non c’è vita. Siamo andati a trovarlo nel suo quartier generale di Bra, sede di Slow Food nonché suo paese natale, e ci siamo fatti raccontare come si possa abbracciare il mondo partendo proprio da un buon bicchiere di Barolo.
Il gusto si forma nell’infanzia: che ricordo hai di ciò che accadeva nella tua cucina natale di Bra?
Innanzitutto quello vivissimo della mia nonna paterna che, con la pazienza e la dedizione che solo le nonne possono esprimere, ha iniziato non solo ad “affinarmi” il gusto con le sue “rolatine in salsa di spinaci” che sono a tutt’oggi il mio piatto preferito, ma mi ha anche insegnato a sbattere la panna per fare il burro, cosa che invece detestavo, e a occuparmi di tutto ciò che rende possibile cucinare. Ad esempio, pulire il focolare e preparare le “balote”, palle di carta di giornale bagnata, pressata e asciugata, insuperabili per accendere il camino. E poi ricordo le vendemmie, la preparazione delle conserve, stagione dopo stagione, e anche i conigli scuoiati e tutta la vita che si svolgeva nei nostri cortili. Insomma, sono cresciuto in un mondo in cui il cibo era un momento di condivisione centrale e rituale, di cui si conoscevano tutti i passaggi, rispettando la fatica che ci stava dietro. E questa esperienza mi ha invogliato a occuparmi di cibo “buono e consapevole”.
Raccontaci i passaggi che hanno portato alla formazione di Slow Food.
Nei primi anni Ottanta avevamo costituito una piccola associazione per studiare la cultura enologica e ho così iniziato a frequentare corsi di degustazione in Francia. Il primo passo è stato lavorare per la promozione dei vini delle Langhe, che ai tempi non avevano ancora sviluppato tutte le loro potenzialità. Ero molto interessato anche all’azione politica e sociale, che in quegli anni erano però nettamente scissi dall’enogastronomia. Incontro fondamentale fu quello con la rivista La Gola di Milano, costituita da un cenacolo di raffinati intellettuali buongustai che avevano già dato dignità culturale e politica alle tematiche gastronomiche, senza tuttavia ghettizzarle e renderle elitarie, come ha fatto invece la Francia. Grazie a questa rivista abbiamo finalmente capito che la piacevolezza del buon vino e del buon cibo poteva, anzi, doveva coniugarsi all’impegno politico e sociale, perché il cibo è elemento indispensabile alla vita stessa: nacquero così l’ArciGola e successivamente i Presìdi, prima iniziativa veramente militante per difendere i prodotti locali e l’immenso patrimonio della biodiversità. E molto lentamente siamo arrivati a fondare Slow Food International nel 1986, a Parigi, con adesioni da parte di Paesi di tutto il mondo. Da qui sono partite altre iniziative importanti come l’Università di Scienze gastronomiche e Terra Madre, che unisce al gusto e alla salubrità del cibo la dignità di chi lo produce, la protezione dell’ambiente e dei prodotti locali.
Si sostiene spesso che non ci sia cibo per tutti, soprattutto tenendo conto che la popolazione è in aumento. Tu cosa ne pensi?
Secondo dati della Fao produciamo cibo per dodici miliardi di persone, mentre gli esseri umani attualmente sono sei miliardi e ottocento milioni, dei quali un miliardo malnutrito e che in parte muore di fame, e un miliardo e settecento che soffre di ipermalnutrizione, cioè di malattie causate da un’alimentazione eccessiva e sbagliata. Quindi non è una questione di mancanza di cibo, ma di una società profondamente sbagliata, ingiusta e non etica, che considera l’uomo non come “essere” ma come consumatore e che per produrre tutto quel cibo sottopone la terra a trattamenti che la depauperano e causano immensi danni. La superproduzione di cibo - e non le industrie o il riscaldamento o le auto - è la prima responsabile del disastro ambientale, della distruzione degli ecosistemi, della biodiversità e della fertilità del suolo, dell’inquinamento delle falde acquifere e della carenza di acqua, e non ho elencato tutto. E questo succede perché la società del consumo si basa su tre elementi senza i quali crollerebbe: la velocità, che porta a consumare e a cambiare di continuo, l’induzione di bisogni non necessari e come terzo, il più grave, lo spreco. Si comprano cose non necessarie, sempre nuove, sempre diverse e poi le si butta via, il mercato del “tutto pronto subito” giustificato dalla mancanza di tempo è sempre più fiorente, mentre non abbiamo mai avuto così tanto tempo a disposizione come oggi. Un esempio banale sono le insalate già lavate nei sacchetti di plastica: costano uno sproposito, sono di qualità discutibile, mentre lavare un’insalata porta via veramente un tempo irrisorio. Bisogna re-imparare invece non solo a lavarsi l’insalata, ma anche a recuperare tutta quella produzione di cibo casalinga, a iniziare dalle conserve, che sembra ormai appartenere a un tempo passato. E indirizzarsi insomma verso il cibo, non per il tempo e il denaro che ci fa risparmiare, ma per il suo valore e la sua bontà.
Ma - faccio l’avvocato del diavolo - la gente dice di non avere soldi e di non arrivare a fine mese…
Ma non diciamo stupidaggini! Negli anni Settanta la famiglia media italiana spendeva il 32 per cento del reddito in cibo, oggi spende il 17 per cento. Questa è demagogia, i soldi non mancano, piuttosto sono spesi per far fronte in modo acritico a tutti quei bisogni indotti di cui abbiamo già detto: nessuno rinuncia ai cellulari di ultima generazione, ai capi alla moda, ai cibi spazzatura reclamizzati, mentre potrebbe destinare quel denaro a cibi sani e buoni. E per questo è necessario parlare con la gente, comunicare, fargli prendere coscienza di tutto ciò.
Una domanda che ci preme molto, occupandosi la nostra rivista di biologico: come mai all’inizio Slow Food sembrava quantomeno diffidente verso l’agricoltura biologica?
In realtà non siamo mai stati contrari all’agricoltura biologica in sé, ma all’atteggiamento integralista di alcuni suoi fautori, che portava a considerarne solo il lato “giusto e pulito” dei cibi mettendo in secondo piano il gusto, che invece è fondamentale come gli altri due. Ricordo ad esempio anni fa dei terribili vini “pulitissimi e giustissimi” ma imbevibili. Poi per fortuna gli agricoltori e i viticultori biologici hanno studiato e perfezionato le tecniche e sono finalmente riusciti a mettere insieme la qualità e il biologico, ossia “buono, pulito e giusto”, tre opzioni non separabili. Ora quel che non mi convince dell’agricoltura biologica è invece il ricorso all’importazione da Paesi lontani: come possono essere “pulite e giuste” delle pere che arrivano dall’Argentina e che hanno sparso carburante in mezzo mondo? La filiera corta insomma, dove possibile, è indispensabile.
Aiutaci a individuare tre cose che ciascuno di noi può fare per contribuire un po’ a cambiare rotta.
Innanzitutto guardare quel che abbiamo nei frigoriferi, che sono il simbolo della nostra angoscia e che testimoniano che siamo ancora attanagliati dal terrore di morire di fame. Sembrano delle tombe di famiglia, nascondono vasetti pieni di muffa e mazzi di prezzemolo avvizziti che chiedono di essere gettati, e nei nostri freezer giacciono pezzi di carne che risalgono al giurassico. In secondo luogo, imparare a fare le conserve, magari recuperando la ritualità e il lavoro collettivo, e poi apprendere l’arte di riutilizzare gli avanzi. Sono solo tre piccole cose, ma da qui si deve iniziare.
Cosa ne pensi dei gruppi di acquisto solidali (Gas)?
Dico che sono sicuramente il quarto consiglio, perché sono la più bella cosa maturata in questo Paese negli ultimi anni e costituiscono un patrimonio che fa ben sperare, perché sono nati in modo spontaneo, non manovrati da nessuno e sul principio di un’austera e sana anarchia, e tali devono rimanere. Per questo è importante che ne nascano sempre di più, ma che restino piccole realtà non strutturate, senza diventare una sorta di “multinazionali”.
E un tuo buon proposito personale?
Suonerà strano, ma io non cucino, fondamentalmente perché ho tanti impegni, perché c’è chi lo fa meglio di me e poi perché non sono abituato alla parsimonia dei mezzi e se mi metto ai fornelli uso una montagna di utensili: fra i miei buoni propositi da mettere in atto quando andrò in pensione c’è proprio quello di dedicarmi di più a quest’arte.