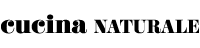Vittorio Sgarbi, critico d’arte, ci racconta la sua passione per l’arte e il cibo, svelandocene i sottili legami.
Interessante e francamente spassosa: così è stata la serata in cui sono riuscita a intervistare l’assessore-onorevole-critico d’arte-professore Vittorio Sgarbi.
Signor Sgarbi, nella sua infanzia ferrarese che posto occupa la mitica “salama da sugo”?
 Benissimo, partiamo da questo piatto sublime e celeste, come d’altra parte sublimi e celesti siamo tutti noi ferraresi: Ariosto, Tasso, Antonioni, Quilici, Balbo, oltre a me, ovviamente. Ferrara è una città metafisica e il suo piatto emblematico è una summa di tutte le meraviglie, indescrivibile. Proprio non ricordo se l’apprezzassi o meno già da bambino: di sicuro posso dire che, malgrado i reiterati tentativi di mia madre di propormi la carne, proprio non la sopportavo, mentre mi piaceva la lattuga che condivo con quintali di sale e olio, e i fagioli: un giorno ne mangiai una montagna, tanto che mi fecero la lavanda gastrica. Ora ovviamente li detesto. Iniziai poi ad apprezzare la minestra in brodo da quando un’amica di mia madre la rese più saporita versandoci l’intera formaggiera, cosa che continuo regolarmente a fare. E, sempre per un trauma infantile, odio il pesce, perché la mia famiglia compiva viaggi interminabili, almeno per me, per raggiungere ristoranti in cui si mangiava esclusivamente quell’alimento puzzolente, mentre col tempo ho imparato ad amare la carne. I miei piatti preferiti sono comunque i semplicissimi spaghetti al pomodoro e basilico e i rapanelli. E in estate il cocomero, col quale ho uno strano rapporto, perché non ci penserei proprio se non mi si parasse davanti con tutta la sua esuberanza di colori, ma al quale non so resistere anche se già a stomaco pieno.
Benissimo, partiamo da questo piatto sublime e celeste, come d’altra parte sublimi e celesti siamo tutti noi ferraresi: Ariosto, Tasso, Antonioni, Quilici, Balbo, oltre a me, ovviamente. Ferrara è una città metafisica e il suo piatto emblematico è una summa di tutte le meraviglie, indescrivibile. Proprio non ricordo se l’apprezzassi o meno già da bambino: di sicuro posso dire che, malgrado i reiterati tentativi di mia madre di propormi la carne, proprio non la sopportavo, mentre mi piaceva la lattuga che condivo con quintali di sale e olio, e i fagioli: un giorno ne mangiai una montagna, tanto che mi fecero la lavanda gastrica. Ora ovviamente li detesto. Iniziai poi ad apprezzare la minestra in brodo da quando un’amica di mia madre la rese più saporita versandoci l’intera formaggiera, cosa che continuo regolarmente a fare. E, sempre per un trauma infantile, odio il pesce, perché la mia famiglia compiva viaggi interminabili, almeno per me, per raggiungere ristoranti in cui si mangiava esclusivamente quell’alimento puzzolente, mentre col tempo ho imparato ad amare la carne. I miei piatti preferiti sono comunque i semplicissimi spaghetti al pomodoro e basilico e i rapanelli. E in estate il cocomero, col quale ho uno strano rapporto, perché non ci penserei proprio se non mi si parasse davanti con tutta la sua esuberanza di colori, ma al quale non so resistere anche se già a stomaco pieno.
Le piace cucinare?
Per carità, dopo aver appreso negli anni Settanta da un senatore comunista i segreti di come friggere la pancetta in modo da cuocere bene sia la parte magra sia la parte grassa ed essermi prodotto in un paio di meravigliose carbonare, ho abbandonato per sempre i fornelli. Sono un maschio ottocentesco e l’uomo in cucina mi fa anche un certo effetto: io sto fermo e aspetto che mi servano.
Ci racconta qualche rappresentazione pittorica di cibo?
Sicuramente le molte opere dei pittori fiamminghi e, restando in Italia, soprattutto le “ultime cene”, a iniziare da quella di Leonardo, dove erano perfettamente descritti i particolari, addirittura l’ombra del vino proiettata sulla tavola, rossa o gialla a seconda del vino contenuto nel bicchiere: ora purtroppo non si vede quasi più nulla. Per avere un’idea di come doveva essere quest’opera, si può osservare una Cena di Emmaus di Giovanni Agostino da Lodi: in esso sono dipinti molti particolari, il sale nelle saliere, l’aceto balsamico, il pollo, la carne e l’insalata rossa di Treviso, essendo il quadro stato dipinto in quella città, e ancora il vino rosso e bianco con le ombre differenti. Citerei poi i quadri di Giulio Romano a Mantova, con i fastosi pranzi di Bacco e Arianna. Per quel che riguarda la simbologia, ricordiamo che il pesce rappresenta il Cristo, l’uva l’eucarestia e il pane la carne di Dio. In periodi di austerità come quello della Controriforma poi, il cibo non era molto rappresentato, mentre si “libera” in età barocca: le tavole imbandite di Veronese, ad esempio, sono dipinte in modo sontuoso ed evidenziano la contaminazione che questo artista compie tra soggetto religioso e vita sociale e mondana. Il mio autore preferito, per quanto riguarda la rappresentazione del cibo, è Francisco de Zurbaran, artista spagnolo del ‘600, che ha dipinto soggetti alimentari in modo meraviglioso e con molti particolari.
Proviamo ad allestire una cena con degli artisti al posto delle portate.
Vediamo, l’antipasto potrebbe essere un Botticelli, il primo un Giotto, il secondo un Carpaccio, ma nel senso di Vittore, pittore veneto della metà del ‘400, e non del piatto di carne cruda a fettine che ne ha usurpato il nome e che ormai è sicuramente più conosciuto dell’artista. Ah, dimenticavo: come dolce metterei Tamara de Lempicka, artista polacca di origine francese dell’inizio del ‘900.